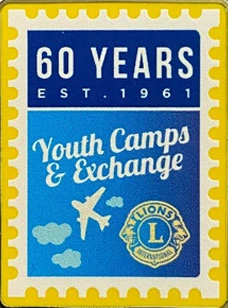Era importante che io capissi quel concetto, lo vedevo dalla loro insistenza nel tentare di spiegarmelo. Azzardavano una parola in inglese, immediatamente seguita da altre per me incomprensibili in giapponese, poi una pausa, un sospiro di frustrazione. Odiavano non riuscire ad esprimersi ed a comunicare con me. “Omotenashi”, mi ripeteva per l’ennesima volta, indicando prima lui, poi sua moglie, poi le mura della casa in cui eravamo e infine me. “Omotenashi”.
La traduzione che mi suggeriva il mio cellulare era ospitalità. “Hospitality?”, chiedevo loro. “No, no hospitality. Omotenashi”, ripetevano di nuovo scandendo ancora meglio le sillabe.
Finalmente capii che mi trovavo di fronte ad un’altra parola intraducibile. Una parola che racchiude radici culturali talmente profonde che non può essere compresa da un traduttore automatico. E nemmeno da qualcuno che non sia mai stato accolto in una casa giapponese. Sorrisi, ripensando ai tentativi di pochi mesi prima delle persone che avevo conosciuto in Brasile di farmi capire il profondo significato della parola “saudade”, anch’essa intraducibile in italiano. Mi aveva affascinato come una semplice parola poteva contenere le emozioni che vivere il Brasile provoca.
E ora, di nuovo, era sufficiente una parola.
“Omotenashi” dissi annuendo. “Intrattenere gli ospiti con tutto il cuore e senza volere nulla in cambio”, ecco cosa significa. Mi osservavano con quei loro occhi dalla forma tanto diversa dalla mia, dovevano accertarsi che io avessi capito. Non volevano la mia gratitudine, non volevano essere lodati per la loro ospitalità. Volevano che io sapessi che avevano fatto il possibile per farmi sentire accolto, per farmi vivere il Giappone nella sua grandiosità e nella sua umiltà e che l’avevano fatto non perché speravano di guadagnarci qualcosa, non perché le loro divinità glielo imponevano, non per senso del dovere. Quello era omotenashi, e tradurre con ospitalità non era abbastanza.
Come io sia arrivato in quella casa dall’altra parte del mondo, con almeno un oceano a distanziarmi da qualsiasi amico o conoscente, è una storia curiosa. Una mail letta quasi per caso, dove la parola Giappone mi aveva soltanto intrigato, lasciato sognante per qualche istante. Razionalmente sapevo che andarmene così a lungo nel bel mezzo dell’inverno non fosse nemmeno considerabile.
Eppure ho iniziato a pensarci. “E la scuola, Nicolas?” mi hanno rimproverato in molti. “E gli impegni sportivi, le gare?” è stato sottolineato da altri. “Davvero vuoi andartene a Natale e a Capodanno là dove non conosci nessuno?” mi chiedevano sconvolti tutti. All’improvviso mi sentivo incatenato e la voglia di evadere è cresciuta. Il Giappone. Il solo pensiero di quelle terre lontane mi dava un profondo senso di libertà.
Ho deciso di accettare. Sono stato altre volte indeciso, ma partire non si era mai rivelata la scelta sbagliata. A metà dicembre, mentre i preparativi e gli affanni per le festività erano sempre più frenetici, io scappavo, andando incontro al sole, verso il misterioso Oriente.
Milano, Parigi, Tokyo, Fukuoka. Il viaggio low cost che avevo organizzato mi aveva stremato. Eppure, atterrato nel Kyushu, l’isola più a Sud del Giappone, mi sentivo un moderno Marco Polo all’esplorazione di terre sconosciute. Era sera, e non avevo idea di come trovare la famiglia che avrebbe dovuto accogliermi. Lo ammetto, mi sembravano tutti uguali. Per fortuna ero io a risaltare in mezzo a quella moltitudine di uomini e donne minuti.
Il mio incontro con i nativi fu quello che i giapponesi amano chiamare “cultural shock”. Entrambe le famiglie che mi avrebbero ospitato e alcuni loro amici vennero ad accogliermi all’aeroporto, tutti curiosi di conoscere il gaijin, lo straniero giunto dall’Italia. All’inizio mi sembrò un’accoglienza formale, che mi sorprese, poi capii che in realtà era solo la prima volta che mi imbattevo con la timidezza nipponica. Mi fecero un profondo inchino, a cui tentai di rispondere con goffi risultati. Solo allora mi resi conto di quanto io fossi impreparato: non sapevo nulla delle loro usanze, della loro etichetta. Ma non era quella la rivelazione più preoccupante. Hanno iniziato a parlarmi. In giapponese. Non sapevano nemmeno una parola di inglese e insistevano a ripetermi gli stessi strani suoni, sempre più lentamente, sperando che io finalmente capissi. Mi sconvolse scoprire che gli abitanti di una superpotenza economica e tecnologica come il Giappone fossero del tutto incapaci parlare inglese. E soprattutto mi fu necessario un intero mese di profonda immersione nella loro cultura isolata dal resto del mondo e con tanti connotati nazionalistici per comprendere l’attaccamento al nihongo, la loro lingua madre.
Inizialmente però non mi preoccupai troppo del fatto che per un mese non avrei potuto comunicare con nessuno e che nessuno sarebbe riuscito a comunicare con me. Anzi, trovavo estremamente divertenti i loro tentativi di farsi capire. Ho imparato subito che tutto ciò che avrei dovuto fare era rispondere “hay hay” a tutte le loro domande e seguirli. Salii in macchina con la mia nuova famiglia, una coppia all’apparenza molto giovane ed affettuosa e i loro tre figli. Il mio ingresso in quella che sarebbe stata la mia dimora per le successive settimane fu forse uno dei momenti più belli, nonostante avessi messo piede sul suolo nipponico da poche ore. Scacciò tutti i miei dubbi, mi fece capire che ero esattamente dove volevo essere.
“Perché rimarrai deluso dal Giappone” era il titolo di un articolo che avevo letto durante il volo. “Il Giappone non è più la terra di antiche tradizioni che era un tempo, ormai è stato completamente corrotto dai costumi occidentali” sosteneva l’autore dopo una visita a Tokyo. Forse ciò poteva essere vero tra le strade principali della capitale, ma non dove ero io. Io ero lontano dalla mondanità del Giappone occidentalizzato, e lo capii appena entrai in quella splendida casa. I muri fatti di carta e legno, il tatami, tavolini alti pochi centimetri da terra circondati da cuscini ricamati. Ad aspettarmi c’erano tutti gli stretti parenti della famiglia, nonni e zii che si inchinarono profondamente, mi invitarono ad inginocchiarmi sul cuscino appositamente collocato per l’ospite e mi versarono tè verde amaro che finsi di adorare, visto che tutti mi stavano osservando in attesa mentre bevevo da quella tazzina delicata. Solo successivamente scoprii che il rito a cui avevo appena preso parte era più antico e complicato di quanto potessi mai immaginare.

Mi fu indicata la mia camera. Enorme, e vuota. Nessun tipo di mobilio, solo qualche sobria decorazione alle pareti e scritte che in seguito scoprii essere le Quattro Nobili Verità del buddhismo. Cercai su Google Traduttore come si dicesse letto, e loro sorridendo mi portarono un futon arrotolato che spiegarono sul tatami. Le prime notti furono complicate, abituarsi a dormire per terra non è semplice, ma in seguito imparai ad apprezzarlo.
“Onsen?” mi chiesero. No, la mia faticosa giornata non era ancora finita. “Onsen, hay hay”, risposi, non avendo idea di cosa significasse. Mi fecero salire in macchina, e io mi inebriavo dalla sensazione generata dall’accadere delle cose senza che io avessi alcun controllo su di esse. Gli onsen sono le sorgenti termali, scoprii arrivato a destinazione. Non avevo portato con me né il costume né l’accappatoio. Cercai di spiegare che dovevamo tornare indietro, ma i miei sforzi erano vani. Solo dopo essere entrato negli spogliatoi capii: decine di asiatici nudi scrutavano me e i miei tratti caucasici. Un po’ restio mi spogliai anche io. Mi diedero un minuscolo asciugamano che misi in testa come tutti loro, senza realmente capirne il motivo.
Mi lavai accuratamente come mi fu mostrato. Ancora non immaginavo la vastità dell’ossessione nipponica per l’igiene. Qualsiasi cosa che non fosse il corpo umano era considerato sporco. Né costumi né asciugamani erano ammessi. L’acqua scottava. No, bruciava. Bolliva, quasi. Soffrii in silenzio mentre il mio corpo tentava di abituarsi a quella temperatura che sembrava assolutamente normale per tutti loro. Quella struttura, metà all’aperto metà al coperto, con vasche in pietra e imponenti statue di kami, era meravigliosa. Era solo la prima serata, ma avevo già sperimentato una componente fondamentale della vita di un giapponese. Le acque termali erano simbolo di relax dopo una giornata di intenso lavoro e la più profonda forma di pulizia del corpo. Per quella dell’anima avrei dovuto attendere il giorno successivo.
Erano le cinque e mezza di mattina quando sentii risuonare tre volte il gong. Poi una cantilena e infine altri rintocchi. Non saprei come definire questo rituale. Sicuramente non è una preghiera, almeno come la intendiamo noi, e nemmeno assomiglia alle nostre lodi mattutine cattoliche. Mi piace pensarla come meditazione guidata. Qualunque cosa fosse, così iniziarono tutte le mie mattine. Seguiva la colazione, così sana e nutriente da farmi venire la nausea solo a ripensarci. Riso, zuppa di pesce e di verdure. No, la mie mattinate non erano semplici.

Poi mi piaceva accompagnare i miei nuovi fratelli dagli occhi a mandorla a scuola. Mi divertiva la fiumana di bambini, tutti vestiti allo stesso modo, che camminava ordinatamente in fila indiana dirigendosi a scuola ripetendo molto educatamente mentre passavo “ohayou gozaimasu”, buongiorno.
Poi solitamente arrivava qualcuno che aveva grandi progetti per me. Amici, parenti e vicini mi portavano a vedere qualcosa di nuovo, un giardino, un tempio, un castello, una città. Il pranzo solitamente lo consumavo in un orfanotrofio gestito dalla famiglia che mi ospitava. Mi ci vollero svariati giorni, numerosi trucchi di magia e qualche riferimento ai Pokemon e a Dragonball per entrare in confidenza con quei bambini.

Intanto osservavo con attenzione tutto ciò che era intorno a me. Tutti i loro gesti, le loro assurdità. Esploravo, leggevo, imparavo il perché dei loro rituali, mi esercitavo con la lingua di cui avevo sempre più crescente bisogno. Mi mancava esprimermi. Mi mancava poter farmi spiegare cosa stava accadendo. Non è facile convivere con il silenzio, soprattutto sopportando il disagio che ciò provoca negli insicuri giapponesi. Talvolta mi spazientivo, non tentavano nemmeno di farsi capire, e i miei sforzi sembravano vani. Il mio processo di integrazione fu tremendamente arduo, e forse proprio per questo motivo mi diede così tanta soddisfazione.
Per capirne la difficoltà è necessario spiegare il complicato rapporto tra il popolo nipponico e chi viene da aldilà del mare. Mi sono sempre chiesto cosa prova un immigrato africano a sbarcare in Europa, in una società così più avanzata della sua. E pensavo che mai avrei potuto provare nulla del genere, finché non misi piede in Giappone. Non mi ci volle molto a capire che mi trovato in un Paese più civilizzato del mio. L’attenzione scrupolosa all’igiene fu il primo indizio. L’educazione e la formalità di tutti i cittadini, la modernità degli edifici, la pulizia delle città, l’inquinamento acustico e la criminalità a livelli minimi furono la conferma. Ero un barbaro ai loro occhi. E così tutti gli stranieri: rumorosi, sporchi, maleducati e criminali.
Sono un popolo contradditorio, questo l’ho capito immediatamente. Tecnologicamente avanzati e ancorati alle tradizioni, formali ed educati e al contempo così impacciati nelle relazioni sociali da cercare il più possibile di evitare contatti con altre persone, precisi, puntali, gran lavoratori ma con uno stile di vita umile e sobrio.
Tornando alla mia quotidianità, mentre mi abituavo alle combinazioni più assurde di cibo, alla monotonia della loro dieta salutista che permette al Giappone di essere la nazione che vive più a lungo del mondo, sorprendevo chiunque incontrassi presentandomi in giapponese e scusandomi educatamente perché “nihongo wa wakarimasen”, non capivo molto bene la lingua. Mangiare con le bacchette smise di essere una tortura dopo che mi fu chiaro come funzionassero, e finalmente compresi la loro abitudine di farsi la doccia (lavandosi molto accuratamente) per poi farsi il bagno con dell’acqua che sarebbe stata riutilizzata da tutti i componenti della famiglia, in scrupoloso ordine gerarchico: l’ospite, il padre, il primogenito, i figli maschi, la madre, le figlie femmine.
Non c’era cosa che la mia famiglia amasse di più dei miei sforzi di imparare la loro cultura. Ogni volta che impugnavo delle bacchette o dicevo una parola in giapponese si complimentavano con esagerate ovazioni.
Arrivò il 25 dicembre, e passò. Quasi non mi accorsi nemmeno che fosse Natale. Non fraintendete, nelle città è pieno di alberi addobbati e lucine, quasi più di quanti ce ne siano in Italia. Ma questo solo perché i negozi e i centri commerciali hanno capito l’enorme potenzialità commerciale di quella festività. Almeno non tirando in mezzo la nascita di Gesù Cristo il loro Natale è un po’ meno ipocrita.
Io invece ero in una zona di profonda tradizione buddhista. Quando non sapevo cosa fare andavo al tempio, la spiritualità della loro religione atea mi affascinava profondamente.
Il mio approccio con il parlato migliorava ogni giorno, ma ancora mi erano completamente incomprensibili tutti quei complicatissimi ideogrammi con cui i giapponesi scrivono. Così decisi che avrei dovuto partire dalle basi, e chiesi ai bambini delle elementari dell’orfanotrofio di insegnarmi a scrivere i kanji. Non mi ero reso conto di quanto anche la semplice calligrafia fosse un’arte quando eseguita da un giapponese. La mente doveva essere concentrata solo sul foglio che avevi davanti e sull’inchiostro nero. Rapide e al contempo meticolose pennellate precedute da svariati secondi di riflessione.
“Sono tutti educati, ti sorridono e si profondono in inchini, ma sotto la loro cortesia percepisco un mare di emozioni. Sono un popolo enigmatico… dal momento in cui si svegliano si dedicano interamente a raggiungere la perfezione in ogni gesto. Non ho mai visto una simile disciplina. Mi ha sorpreso scoprire che la parola Samurai voglia dire: servire.” (dal diario del capitano Nathan Algren, “The last Samurai”)

Si avvicinava il capodanno, la festa più importante del Giappone. I preparativi iniziarono con più di una settimana d’anticipo. Le case furono completamente pulite e riordinate. Tutto ciò che c’era di vecchio da buttare fu buttato. Vennero scritte centinaia di cartoline da inviare ad amici e parenti per augurar loro un buon anno nuovo. Ogni istante era impegnato a preparare decorazioni floreali, costruire strutture di bambù, preparare complicate torte di riso.
La sera del 31 organizzarono un cenone non molto diverso dal nostro, con abbondanza di cibo e di sake. Come proseguì la serata invece, quello sì che era completamente diverso dalle nostre abitudini. E devo ammetterlo, anche qui i giapponesi hanno solo che da essere presi d’esempio.
Mancavano pochi minuti a mezzanotte. Un altro rintocco di gong. Era il centoquattresimo. Intorno a me centinaia di giapponesi ripetevano ininterrottamente le loro preghiere melodiche. Ecco il centocinquesimo, ne mancavano solo tre. 108 rintocchi salutavano l'anno che terminava, uno per ogni desiderio mondano dell'uomo. "È ciò che ci impedisce di essere felici, di raggiungere il Nirvana", mi avevano spiegato. Centosei. Un suono semplice, quasi primitivo. Un suono che parla di una storia vecchia di tremila anni. Centosette, scoccò la mezzanotte. Centotto. Ci mettemmo in coda, ognuno di noi avrebbe potuto suonare quell'enorme campana per augurare un buon anno nuovo all'intera città. Mentre ascoltavo le profonde vibrazioni del mio rintocco pensai al conto alla rovescia occidentale, al brindisi. Apparivano così banali di fronte a quel rito così significativo.
Mi avvertirono subito che avrei dovuto stare attento alle mie "prime volte" dell'anno nuovo. Il primo saluto, il primo inchino, il primo sorriso. Mi consigliarono poi di andare a riposarmi un poco, il primo giorno dell'anno è anche il più faticoso.

Mi vennero a svegliare alle quattro, era ora di mettersi in cammino. Iniziammo la nostra ascesa alla collina più alta della città nel buio più completo. Mi resi conto che non era un luogo scelto a caso, un suggestivo percorso di torii e templi che al buio erano ancora più suggestivi e mistici. Arrivammo in cima quando l'aurora iniziò a schiarire il cielo. In migliaia ci avevano preceduto. Erano tutti lì per salutare la divinità shintoista principale, Amaterasu, dea del sole. Non era la prima volta che attendevo l'alba, conoscevo il fremito dell'aria nell'istante prima che il disco solare comparisse. Ripensai a quando lo vidi innalzarsi tra le rocce del Grand Canyon, a quando aveva illuminato le gelide acque del Mare del Nord in cui ero immerso. Ora era il Sole rosso rappresentato nella bandiera del Paese del Sol Levante a scaldarmi il volto infreddolito,era l’hatsuhinode, la prima alba dell’anno.
La giornata proseguì tra innumerevoli riti propiziatori e assurde superstizioni. L’elaborato kimono che mi era stato prestato per l’occasione suscitava sguardi incuriositi di chi probabilmente non aveva mai visto stranieri con il vestito cerimoniale tradizionale. Ma ormai ero uno di loro, e lo mettevo subito in chiaro con un inchino della profondità adeguata all’occasione, all’età e al genere di persona che mi trovavo davanti.
Mancavano però pochi giorni al mio trasferimento con un'altra famiglia, in un'altra città. L’imminente addio mi aiutò a rendermi conto di quanto affetto provassi per quella famiglia. Iniziai a cucinare piatti italiani per loro, un po' perché quella monotonia culinaria iniziava a farsi insopportabile, un po' per dimostrare la mia profonda gratitudine. Passavamo ore a fare quelle nostre strane conversazioni dove nessuno capisce realmente cosa intende l'altro. Era però tempo di salutarli. Vorrei dire che dignitosamente seppi nascondere le lacrime, ma non sarebbe la realtà.
Si apriva un altro capitolo della mia avventura, completamente differente. Dopo aver sperimentato il Giappone più umile e tradizionale con la mia seconda famiglia ebbi occasione di conoscere tratti particolari della cultura moderna del Paese del Sol Levante.
La famiglia era benestante, la casa era lussuosa e io dormivo su un vero letto. Visti i pochi giorni in cui mi avevano a disposizione gli anziani coniugi che mi ospitarono si dedicarono completamente a soddisfare ogni mia rimante curiosità sul Kyushu. Mi portarono a vedere il tempio Yutoki, di gran lunga il luogo più esteticamente bello che io abbia visitato, le mistiche grotte di Takachiho e soprattutto, Hiroshima e Nagasaki. Devo ammetterlo, entrambe le visite mi hanno scosso profondamente, mettendo in discussione tutte le mie convinzioni che avevo sull’argomento.

Ironicamente, in contemporanea ai momenti più spiritualmente intensi della mia permanenza in Giappone, scoprii il lato più giovanile e perverso del paese. Il figlio minore della coppia che mi ospitava, ventisette anni, si premurò che la mia esperienza fosse completa in tutti gli aspetti. Iniziarono così notti brave passate nei karaoke (che significa “orchestra vuota” in giapponese) nonostante le mie imbarazzanti prestazioni e negli hostess club. Riguardo a cosa siano gli hostess club preferisco che vi documentiate da soli, anche se non mi aspetto che sia chiaro il senso di quei locali e soprattutto perché siano così meravigliosamente divertenti.
Inutile dire che avevo smesso di dormire negli ultimi giorni. Avevo insistito per imparare più arti marziali possibili, così ogni mattina alle cinque mi esercitavo nelle scuole superiori locali a karate, judo o kendo, il mio preferito. E mentre la mia “via della spada” migliorava, i giorni della mia permanenza stavano per terminare.

Chissà perché il Giappone mi abbia reso così emozionalmente fragile, ma salutare tutti quei visi che finalmente avevo imparato a distinguere fu più complicato del previsto. Vennero tutti a dirmi addio. Dall’anziano signore che mi aveva portato a giocare a golf alla famiglia del ragazzino con cui giocavo a baseball. Erano lì tutti, per me. Per la prima volta fui felice di non sapermi esprimere nella loro lingua. Non avrei saputo cosa dire.
Quando ringraziano, i giapponesi ringraziano più di una volta. I loro ringraziamenti anche per cose banali durano ben oltre la normalità. Io non sapevo come fare in modo che capissero la mia estrema gratitudine, ma sono convinto il mio sguardo sia stato capace di esprimersi al posto mio.
Dovevo affrettarmi, iniziavano le procedure di imbarco per il mio volo per Tokyo. Li guardai un’ultima volta. I loro occhi stretti, il loro naso schiacciato, le loro corporature minute e graziose.
Sayonara, namo amida. Arrivederci, tornerò.
Non si parla d’altro che di separazioni, muri e frontiere. Forse è il caso che si parli di più di intercultura, di integrazione, di omotenashi.
Complimenti al Lions Club International per questo grandioso progetto di scambi giovanili, formare gli adulti del futuro con ampie vedute è un’attività non sufficientemente valorizzata.
Se ora io mi sento Cittadino del Mondo è grazie al vostro lavoro.
Arigatou gozaimasu.